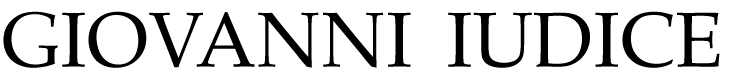“Visibile…Invisibile”
La pittura di Giovanni ludice mi giunge nuova, anzi antica, con un misto di attualità immediata e di memoria lontana, introducendo un’ambiguità creativa che è tipica di tutte le zone di confine, dove si gioca la grande partita tra continuità, intesa come filologia di un passato che ha, ancora, tante cose da insegnarci (e noi da imparare), discontinuità, come viaggio nell’universo sconosciuto della realtà, che man mano ci appare, e l’esuberante vitalità del sogno che attua i desideri, per quanto metafisici o surreali possano apparire.
Si tratta di una fisica del quotidiano, che mette in scena i gesti e le movenze della normalità, colti nell’attimo fuggente del loro svolgersi e trasformati in icone significative del nostro tempo, che è anche il suo, in una grande attuazione con i colori morbidi della pittura che riprendono le linee decise di un disegno che c’è sempre, anche quando non si vede.
Ed è, appunto, questa la struttura significante del lavoro sulle vicinanze immediate della sua vita di relazioni, con il corpo femminile, con le scene di
gruppo, con le vedute paesaggistiche, che chiudono il cerchio intorno al suo immaginario, tanto febbricitante nel suo essere intimo e sensuale, quanto solare nel suo apparire narrativo e dialogante.
Tutto sembra scorrere normalmente, in un universo di gesti e di movenze che composti insieme possono mettere a segno delle intere biografie della normalità, che non sono mai schiacciate in una sola dimensione, ma sono vivificate da una cromaticità soffice che diventa corporeità virtuale, avvincente, affascinante, che in certi momenti è più reale del reale, tanto da tramare un inganno alla percezione immediata, quella che si stampa nella memoria e diventa indelebile presenza del monologo interiore, quello che si richiama al silenzio delle parole, che è fatto di niente ma è linguaggio assoluto.
Nella vasta gamma del visibile, Giovanni ludice esprime, anche nel disegno, una grande volontà di appropriazioni della vita che lo circonda, con la
forza di un’astrazione formale, che diventa la dilatazione del suo squardo “scientifico”, indagatore di sorrisi e di indifferenze, che nel tracciato netto della matita fanno architetturalità, mentre nella sfumatura riempiono gli spazi interstiziali, delineando il territorio intimo dove tutto si tiene nel segno in sé, che diventa astrazione.
Avviene, cosi, il paradosso che un massimo di concretezza, un verticalismo di mimesis, diventi astrazione, accogliendo una vocazione intima del disegno che, alla fine, non somiglia ad altri che a sé stesso, anche se ha lavorato sulle singolarità realistiche, che non cessano affatto di essere tali quando diventano simboliche, espressioni di uno spirito del tempo.
Comunque tra disegno e pittura, in Giovanni ludice, c’è un rapporto totalitario, di osmosi, con un continuo trapasso di esperienze formali, non ascrivibili a un prima e a un dopo, perché questo richiamerebbe un disegno come primo tempo della pittura, configurandolo come studium, mentre alla pittura non potrebbe che toccare il punctum. Ma non è così, perché a questo disegno tocca l’onere dell’essere un’opera finita, quindi di specchiarsi sulla pittura costituendone un doppio, fatto di essenzialità strutturale, una sorta di radiografia sui generis che scende sotto la trasparenza della pelle, mettendo in luce tutto l’apparato labirintico che pervade le sensazioni dell’oggettività, sia quelle delle situazioni ambientali che delle immagini umane, in preminenze di nudo femminile.
Sottolineare le peculiarità del disegno mi permette di cogliere il suo modo segreto di rapportarsi col visibile, cogliendo quell’estremamente visibile che è tanto esposto nella sua nudità metaforica da scomparire, da tradursi in sostanzialmente invisibile per precipitazione nell’altro da sé, come se venisse colto in un ambito formale esorbitante dalla nostra strettoia, accecata da ultravioletti e infrarossi.
Nel disegno, lavorato in maniera certosina, come un tessuto irrorato da un misterioso scorrere di linfe vitali, colgo le impronte di una calligrafia che lo accomuna all’ontologia di Antonio López García, in ricordo di una lontana comunanza edenica da cui ognuno parte inesorabilmente per seguire un proprio percorso che in parte è intenzionale, in parte è in deriva inevitabile, fino ad arrivare alle quiete piegature di un Dennis Hopper, nella sottolineatura delle contaminazioni essenziali e fondanti con il mezzo fotografico.
Perché, appunto, il mezzo fotografico è assunto come trasportatore d’immobilità, al flusso e alle dinamiche di quell’opera di luce in cui, noi tutti, siamo soggetti e oggetti, in cui tutto avviene, nel pieno del giorno, nell’incombenza di ogni crepuscolo e nella paura della notte, che è la prefigura ossessiva della morte.
Con questo, non voglio dire che ci sia solo un flusso del disegno sulla pittura, ma ci sono due flussi particolari, perché dalla pittura viene quel senso pieno, che c’è anche nel disegno, di un anticlassicismo con venature espressionistiche, sia senza forzature di toni e di forme, delineando uno scorrimento che, prima d’essere reale qual è, appare immerso nel pieno dell’altro da sé, perché è mentale, frutto di un desiderio, di un inconscio desiderio di rovistare nella vita degli altri, stando attento a non distoglierli dalla vita di tutti i giorni, che è poi la vita pura e semplice dei singoli, dei tanti, di molti, di tutti.
Eppure non finisce di sorprendere, sospendendo, ogni volta, l’attenzione alla tramatura preziosa della composizione e conciliandola poi con il suo tono generale, che restituisce la totalità di ogni singola opera, come anello di una catena fatta di mille diversità che non discendono da nessun modello, da nessun ideale, ma sono l’esito di un fermento della singolarità che è frutto del caso, della necessità, ma anche di una cultura che inventa e sovverte ogni cosa.
C’è del Freud in questi lavori, c’è del Cooper, c’è del Musil, c’è del Proust non già in referenza diretta, ma come aura cangiante, assorbita dalla porosità della pelle, da una trasposizione che è possibile in quanto questo mondo appartiene a ludice nella sua interezza, perché lo conosce in tutte le sue sfumature, ma non per questo finisce di ammaliarlo, tanto da indurlo a dedicargli i capitoli di questa enciclopedia immaginaria, dove le addizioni e le sottrazioni si eliminano a vicenda e lasciano ogni volta un grado zero, per cominciare di nuovo a seguire la linea d’ombra, ma anche quelle della luce.
Il carattere postmoderno di questa pittoricità è tutto concentrato nel superamento di ogni tradizionale tematica dell’impegno, così come potrebbe suggerire la sua situazione a Gela, che ad altri avrebbe potuto indurre una tematica sociale, locale, che ludice ha sempre respinto, concentrandosi nei luoghi dell’intimità della segretezza.
Penso al nudo femminile, colto nella sua naturalità aurorale, senza trucco e senza pesante scenografia, senza perseguimento dei miti della bellezza, a cui i grandi media costringono tutti, inducendo a costosi rifacimenti di labbra, seni, cosce, pance, mani, piedi, costituendo una megaofficina della bellezza che, sottostando al sistema della moda, non fa delle acconciature definitive, ma allestisce delle teatralità provvisorie e reversibili.
A Giovanni ludice interessa il tasso di realismo immediato che gli dà il fermo immagine dello scatto fotografico, mettendosi in concorrenza con oqni cinematica, rovesciandola nel suo opposto e quindi scoprendo un visibile che a occhio nudo è invisibile, per cui c’è sempre un emanazione di sorpresa che rende enigmatiche anche le cose più conosciute.
Le donne di Giovanni ludice sono indifese, così come i suoi bagnanti, i suoi migranti, i suoi rari amanti, spiati per essere affermati come referenti di una contemplazione in cui ognuno ricostruisce una propria icona o un proprio idolo a cui rivolgere uno squardo rituale che ha il valore di un conoscere e di un conoscersi, che è un itinerarium che si chiama Narciso, in quanto essenziale specularità di sé stesso.
Un certo tema dell’impegno, ma teso più alla lettura fisionomica dei volti e alla mimica dei gesti, lo ha sottratto alla cronaca dei migranti provenienti dai luoghi più diversi, attraverso deserti e mari, per venire da noi: lui li coglie nell’ultimo miglio con un caravaggesco realismo, senza bandiera, governato dal dolore e dalla speranza, come a dire che il rapporto stretto con sé stessi non preclude, anzi afferma, l’essenza corale di un linguaggio creativo.
Nel pieno di un anacronismo totalmente appartenente alle qualità rizomatiche del nostro tempo, quest’incontro con Giovanni ludice mi conferma lo sconfinamento dell’arte contemporanea nell’impossibilità di coglierne tutte le contaminazioni, perché qualcuna finisce sempre con lo sfuggire, in un mac-chinismo di completa teatralizzazione del mondo in cui è ancora possibile anche l’impossibile.
Come lo stare appartato in un angolo speciale della Sicilia dove un giorno, prepotente, è passata la storia e oggi impietosa passa la cronaca, vivendo in un proprio regime d’individualità in una campana di vetro, straniante, che lascia fuori tutto ciò che non appartiene alla propria psicologia linguistica, formale, olfattiva, tattile, per formulare una propria singolare esperienza del saper vedere che chiede ospitalità alla storia – per quel tanto che tutte le forme e tutti gli accadimenti sono storici – ma poi tratta le stanze, i giardini, le strade, le piazze della sua vita come codici che necessitano di un’ermeneutica leggera, che sappia leggere ciò che in essi avviene ma senza analisi dissacranti e distruttive, da spiriti inquieti, in preda a eterno furore.
Giovanni ludice ha un atteggiamento morandiano che non si lascia trasportare dalle emozioni e dalle ossessività, che pure gli appartengono in sfera intima, per trattare con compassatezza, direi chirurgica, i suoi riferimenti di un hic et nunc che ha un grande spessore, che appassiona chi come me, dai molteplici incontri con Cesare Musatti ha mutuato una cultura del sospetto che dietro ogni muro ci sia una cassaforte, dietro ogni specchio ci sia un antro segreto, e qui una pittura fortemente poematica, coinvolta oltre le apparenze e le evidenze, nei solchi negati degli archetipi e delle remote quintessenze.
Francesco Gallo Mazzeo
in Catalogo Giovanni Iudice Gam Palermo 2009 ed Charta, milano