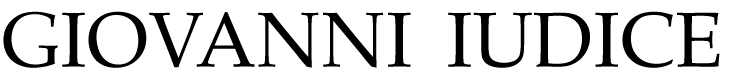Sono questi alcuni dei versi che compongono il brano Imagine di John Lennon, una delle più belle canzoni di sempre che, scritta nel 1971, combina a un suono melodico, che pare una ninna nanna, una pungente argomentazione sociale spingendoci a immaginare un mondo possibile, un mondo in cui si pensa più a costruire ponti che a edificare muri ma, come canta Lennon ad un certo punto, siamo in molti a pensarla allo stesso modo ma spesso temiamo di essere soli “Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo” lasciando che il mondo vada come vada.
Giovanni ludice, nato e cresciuto a Gela nel 1970, dove ancora oggi in modo ostinato vive e, in modo ostinato combatte la sua condanna naturale alla solitudine e alle contraddizioni della sua amata Sicilia, pare trasformare in pittura le parole di denuncia di John Lennon perché l’unica cosa che lui vuole è proprio che non si lascino perdere le cose. Dalla metà degli anni 2000 infatti, la sua tenacia e forza di volontà – spesso ancora oggi dopo molti anni che ci conosciamo mi confessa “lo so di essere testardo” – lo ha portato a mettere su tela, come in un racconto, il dramma che milioni di persone vivono lasciando il loro paese per trovare una vita migliore: i migranti. Ragazzi provenienti da diversi stati, dal Senegal, dalla Tunisia, dalla Libia e dal Congo, in Sicilia si incontrano un po’ ovunque. Uno dice che da grande vorrebbe fare il pugile, un altro che vorrebbe fare il musicista, altri che vorrebbero terminare gli
studi ma tutti hanno un solo obiettivo: non subire più le atrocità della guerra, la violenza delle guardie armate e le intimidazioni dei fucili. Il loro viaggio è una sfida che Giovanni narra sulle sue tavole intervallando a volti di persone, vedute della sua terra ricca di forti e amare contraddizioni. L’interesse di Giovanni per il reale lo avvicina molto ai film di Federico Fellini o a quelli di Pier Paolo Pasolini, in particolare nel loro intento di ritrarre una vita vera, fatta di gente che dice quel che pensa anche se sono pensieri tremendi. I suoi disegni a matita paiono volutamente ingannevoli al punto di avere il dubbio di trovarsi davanti ad una fotografia. Nulla di male in questo perché lui, attraverso la ricostruzione minuziosa dei dettagli, dà una connotazione emotiva alla fotografia come nel caso della Natura morta con ossa nel piatto realizzato nel 2010. Una tavola apparecchiata, un piatto con avanzi di pollo e sullo sfondo un televisore acceso con il volto di un clandestino che guarda verso di noi.
“Avevo appena finito di mangiarlo io quel pollo” mi racconto Giovanni qualche tempo fa – “e, come spesso avviene nella nostra consuetudine, avevo acceso il televisore sul quale correvano immagini di clandestini e immigrati.
Ormai ci facciamo un’idea della realtà attraverso la televisione, un media di consumo molto veloce, che ci bombarda di messaggi. Ero li, ed è come se a un certo punto mi fossi sentito in dovere di far partecipare alla mia cena un clandestino”. Un racconto di cronaca tradotto in poesia, come un reporter dei sentimenti che descrive momenti di vita vissuta che non hanno nulla di sorprendente in sé ma sono pieni di una disarmante intimità. Il suo racconto, fatto di iperrealistiche e puntuali descrizioni di uomini, di luoghi e di mari, talvolta slitta verso il piano dell’immaginazione e della fuga nella memoria del racconto come in Nuvole a Venezia, del 2012, dove si apre uno spiraglio surreale. Quasi come in un sogno, una barca affollata di clandestini dai volti bruciati dal sole, le mani callose e gli occhi affaticati sembra terminare il lungo ed estenuante viaggio in una Venezia incantata.
La sensazione di una città romantica si lega alla speranza di una vita migliore. Una pittura dai blu intensi si unisce adesso ai toni soavi e tranquilli dei palazzi e ad una luce che sembra essere presa in prestito da un paesaggio di Canaletto. Un’atmosfera che rasserena, quasi a voler dire “finalmente, ce l’abbiamo fatta”; un mare che non è più simbolo di paure e di morte ma che sembra invece cullare la barca verso un silenzioso approdo. Alcune nuvole portate dal vento del passato nascondono o vestono una presenza, forse i piedi di un compagno perso nel viaggio.
Un lavoro questo, che, come spesso accade, ha visto la luce dopo mesi di lunghi e intensi scambi di corrispondenza con chi per lui è stato un ponte con il mondo reale che ha deciso di non vivere: il mondo delle soirée esclusive, dei balli del sabato sera in abito di gala seguiti dal brunch della domenica mattina, il mondo della gente sempre connessa, sempre in preda all’affanno di non farcela e senza mai un minuto da perdere, il mondo da bere, spesso poco attento ai dettagli e frettoloso nelle scelte, ma anche il mondo che aiuta, senza chiedere nulla in cambio, che anzi è aperto ai cambiamenti e generoso nei momenti difficili. Generoso, proprio come lo sguardo di Giuseppe lannaccone, un avvocato collezionista, parecchio conosciuto oltre che per i suoi grandi processi e la sua importante collezione d’arte internazionale, anche per la tenacia, l’altruismo e il suo grande amore per il Sud, la terra dove è nato e dove ha vissuto la sua infanzia e dove fa ritorno ogni volta che gli è possibile, vuoi per una questione professionale, vuoi per il suo Napoli o vuoi per andare a ritrovare i volti dei suoi amati famigliari o solo per rivedere il mare. Non manca mai, nelle telefonate quando è in trasferta in Sicilia o a Napoli, una frase dedicata ai luoghi: “è tutto irresistibile e magnifico”. Uomo di grande sensibilità, Giuseppe lannaccone, ha da sempre curato il lavoro di Giovanni di cui si innamorò osservando un piccolo disegno alla Fiera di Bologna nel 1998, una spiaggia popolata da una moltitudine di gente che, ammassata, tentava di trovare un poco di refrigerio in quel luogo scottato dal sole del Sud. Un artista che da quel momento in poi lannaccone sostenne in modo caparbio, nonostante tutti gli dicessimo fosse una follia, permettendogli prima, di smettere di fare l’infermiere per dedicarsi a tempo pieno alla pittura e poi aiutandolo quotidianamente sia con conversazioni puntuali e attente su quanto accadeva nel mondo sia comprandogli le più belle opere che Giovanni abbia realizzato. “Da questo momento in poi” racconta spesso l’avvocato “ è iniziata tra noi una relazione umana che è andata ben oltre il mero rapporto artista-collezionista. Forse per la prima volta si può parlare di un’osmosi totale, perché io non mi sento solo colui che gli compra le opere, ma una persona con cui discute d’arte e parla dei progetti futuri”.
Ed è così che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, Giuseppe lannaccone è arrivato ad avere oggi circa una sessantina di suoi lavori. Opere da quelle più personali dedicate ai ritratti dei suoi amati figli a quelli più di denuncia, nati appunto dalla grande sensibilità di confronto tra Giovanni e l’Avvocato. “I nostri incontri” – prosegue lannaccone quando racconta la loro storia – “si infittirono, veniva spesso a trovarmi a Milano e percepivo in Giovanni una tensione positiva che mi ricordava la necessità di scavare nell’animo umano, nella sofferenza fisica e piscologica di uomini sopraffatti dalla vita che Fausto Pirandello aveva ben espresso nelle sue tavole stracolme di corpi sfatti e nudi sulle spiagge dei primi anni Trenta. Leggevo negli occhi di quel giovane artista uno slancio verso la sua amata Sicilia … Questa grande passione verso l’animo umano si è tramutata, a partire dalla metà degli anni Duemila, in un nostro dialogo costante sull’immigrazione. Penso che Giovanni abbia riconosciuto nella figura del clandestino una delle icone più rappresentative del contemporaneo, un nomade pieno di speranze che immagina la terra promessa con la morte nel cuore per la patria che ha lasciato. Fin da subito ho avuto la sensazione che i suoi dipinti dimostrassero una presa di coscienza forte del problema immigrazione che ancora oggi, passati più di quindici anni, occupa le pagine di cronaca dei quotidiani”. Oggi questi lavori sembrano essere dedicati agli occhi miopi di politici di propaganda, di gestori di hedge fund e di agenzie di “valutazione del rischio” che vivono in un universo tutto loro, in un’atmosfera che ha il sapore di Antico Regime, che di fronte ad una crisi come quella che da anni stiamo vivendo, si preoccupino solo di dove spostare i loro soldi per diventar più ricchi o, ancora peggio, di lasciare centinaia di persone in mezzo al mare per combattere un braccio di ferro con Bruxelles, così da avere più soldi e meno uomini.
Nonostante da qualche tempo Giovanni sembra voler abbandonare il tema dei migranti perché sempre più utilizzato a fini propagandisti, dall’altro non riesce a non fare i conti con la realtà che lo circonda e, senza far rumore, ci ha regalato Asino, 2018 d.C.
Da un lato, una tavola racchiusa in una cornice fatta di materiali grezzi, metallici, corrosi dalla ruggine, estranei alla tradizione, che ricordano le imbarcazioni dei profughi. Volti di clandestini si affacciano da questo oblò con lo sguardo diretto verso di noi, spaventati ma desiderosi di vivere, descritti con autenticità e crudezza, stipati quasi a togliere il respiro, rappresentati in un realismo tale da far sentire il rumore delle onde che sbattono sul metallo del barcone. L’artista, che si raffigura in un angolo della tavola, spogliato dei suoi abiti, sembra quasi voler condividere con loro la sofferenza che anche lui ogni giorno prova verso la sua amata terra e che descrive nell’altro pannello laterale. Sofferenza per le contradizioni nel paesaggio che, rurale, arido e abbandonato dal tempo fa pensare al passato senza immaginare un futuro; sofferenza per le contraddizioni fra visioni di gente ostile al cambiamento e l’umanità di uomini pronti a dare la vita per gli altri e che troppo spesso si sentono soli.
Soli, come quell’unico papavero rosso che, simbolo di pace, nel suo unico giorno di vita, campeggia orgoglioso tra i colori terrosi di Sicilia. Indifferenza per gli “ultimi”, come quel bell’asino, che, con uno sguardo attonito e orecchie dritte, ci osserva dalla cima di una duna, quasi a rimproverarci per la nostra incapacità di capire il dolore, lo stesso che attraversa gli occhi di Masha, l’unica donna protagonista dell’oblò e che Giovanni ci ripropone nella tavola centrale a chiudere il trittico. Una forte presenza fisica è quella di questa giovane donna che, seduta su un trono a noi invisibile, in un paesaggio notturno, dove tutto riluce del chiarore lunare, pare una moderna Madonna con Bambino.
I capelli sono nascosti da un abbondante mantello bianco caratterizzato da un delicato motivo floreale facendo risaltare i lineamenti del suo bel volto che, nonostante sia affaticato dal lungo viaggio, è felice per la nascita di Mobruk, il figlio che tiene sulle sue ginocchia. Quasi come in un collage il neonato – diverso da lei per tratti e colore – pare essere ritagliato e posato tra il manto di colore blu, simbolo del cielo e quindi del divino, e quello rosso che al contrario, nella tradizione pittorica è il colore del sangue e quindi della natura umana.
Ne “Il giorno della civetta”, Leonardo Sciascia descrisse l’umanità attraverso un dialogo tra Don Mariano Arena e il Capitano Bellodi: “lo ho una certa pratica del mondo. E quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini, i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini. E invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo”. Sciascia, negli anni sessanta, parlava di Sicilia, di denuncia alla mafia e di omertà. Oggi si parla di Italia, di Uomini, di cambiamento ma alla fine, seguitiamo a lasciare tutto com’è.
In Pratica 6,
dalla Collezione Giuseppe Iannaccone, Milano